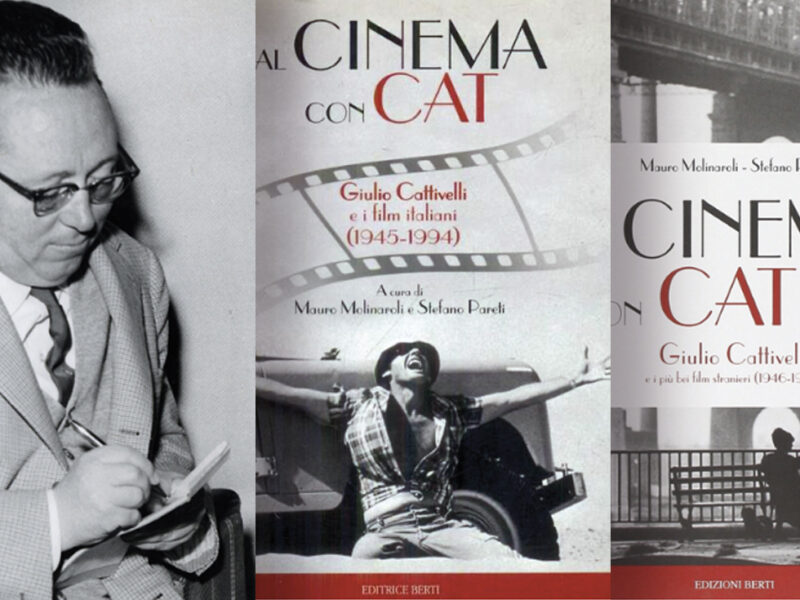Regista sul terreno fertile dell’irrisolutezza
«La figura dell’intellettuale in crisi è sempre un modo per raccontare altre cose, perché non c’è niente di più penoso che raccontare un intellettuale in preda ai suoi problemi. […]
Certo, per fare qualcosa di bello bisogna partire da questioni che uno sente molto profondamente, che non significa banalmente raccontare guardando il proprio ombelico. Ci vuole un cinema estremamente passionale in cui l’autore partecipi attivamente a ciò che racconta, che conosca la materia trattata».
Marco Bellocchio, in occasione della consegna del Premio Maria Adriana Prolo alla carriera. 7 giugno 2008.
Matteo Pollone
Di tutti i cineasti emersi nel corso degli anni Sessanta in Italia, Marco Bellocchio è certamente quello che nelle sue opere ha saputo restituire al meglio l’irrequietezza di molti personaggi del cinema della modernità. Non solo, come sempre si dice, per la portata “incendiaria” del film d’esordio, I pugni in tasca, spesso indicato come ricettore di un malessere diffuso che sarebbe poi esploso pienamente con il ’68: anche dopo la fase della “rabbia”, il cinema di Bellocchio ha saputo evolversi senza perdere mai quel nucleo perturbante di mancata riconciliazione, di ambiguità, di dubbio. Ciò è più che mai vero in quei film che appaiono come “laboratori” o quelli che lo sono davvero, come Sorelle, nato nell’ambito delle lezioni di “Fare Cinema” a Bobbio, chiuso una prima volta nel 2006 e poi riaperto, per uscire nuovamente nel 2010 come Sorelle Mai.
Nella conclusione della prima versione, Donatella Finocchiaro intona una strofa di “E la partenza per me la s’avvicina”, un canto tradizionale delle mondine, mentre sullo schermo scorrono i volti di molti altri personaggi femminili di Bellocchio: Paola Pitagora ne I pugni in tasca, Pamela Villoresi ne Il gabbiano, Nathalie Boutefeu ne Il sogno della farfalla, Maya Sansa ne La balia e infine Maruschka Detmers ne Il diavolo in corpo. Qui Bellocchio si autocita, come ha già fatto e come farà ancora in futuro. Eppure, pochi autori possono dire di aver evitato la trappola della maniera di se stessi come lui. Pochi, in altre parole, possono dire di compiere un percorso di ricerca espressiva che li conduce costantemente verso nuovi territori (anche da un punto di vista tecnico) senza scalfire la riconoscibilità di un corpus che appare coeso anche nelle sue esperienze più periferiche e apparentemente marginali. Basterebbe paragonare le scene del Maxiprocesso di Palermo ricostruite per Il traditore con i filmati televisivi d’epoca per rendersi conto con quale forza il regista sappia fare suoi gesti, parole e interi contesti senza apparentemente intervenire più di tanto su di essi. Nella maestosa e terribile rappresentazione della psicopatologia del crimine che mette in scena nel film del 2019, anzi, Bellocchio ha lavorato in sottrazione rispetto agli elementi inquietantemente grotteschi che la realtà ci ha fornito. Ciononostante, ritroviamo in quelle immagini l’eccesso teatrale che infiamma quasi ogni film del regista, le sentiamo indiscutibilmente sue.
Ma le immagini del finale di Sorelle non rimandano solo a un percorso autoriale coerente e ancora fecondo. Rimandano anche alla severità, al rigore di Bellocchio, che sfuma senza rimpianti una scena di grande bellezza quando rimette mano al film, quattro anni dopo. Certo, nella sua apertura indeterminata verso un futuro incerto («partirò, farò partenza…» canta Donatella Finocchiaro) quelle immagini erano in qualche modo aperte. Eppure rimandavano indiscutibilmente all’idea di un finale, esprimendo qualcosa di definitivo. Anche questa apparente contraddittorietà è tipica del regista, e si esprime forse al meglio in quei momenti che sembrano al contempo dentro e fuori la realtà fenomenica, verso una deriva psichica che non esplode mai pienamente, magari grazie a situazioni spinte al limite (si pensi allo straordinario incipit di Marcia trionfale) senza mai deformarsi esplicitamente in paradosso. «Ma che dite? È un sogno?», chiede alla fine del film il protagonista di Il principe di Homburg: «Un sogno, certo. Che altro?» è la risposta che gli viene data, con la massima naturalezza.
Nei minuti finali dei suoi film, Bellocchio sembra sempre rilanciare l’ambiguità, mai scioglierla. È così nella passeggiata/morte di Aldo Moro in Buongiorno notte, nel campo/controcampo impossibile che chiude Il regista di matrimoni, e altrove. Sono sussulti, possibilità colte all’ultimo, aperture che ci parlano di un cinema che è ricerca, possibilità. Un cinema che non cerca la sintesi tra gli opposti, anche quando si spinge alle estremità (come per il diario e il sogno di Vacanze in Val Trebbia), e che da più cinquant’anni trova in questa irrisolutezza terreno fertile per nuove sperimentazioni.
Matteo Pollone
Primopiano Marco Bellocchio
1 – Marco Bellocchio. La rabbia, la passione
2 – Da una A di sessant’anni fa a una Z ancora tutta da immaginare…
3 – La contemplazione e il mistero delle immagini
4 – Un uomo, un intellettuale, fedele a se stesso
5 – Regista sul terreno fertile dell’irrisolutezza
6 – “Vecchia Piacenza sei piena di sorprese”
7 – “Dialettica dell’andare e del tornare”